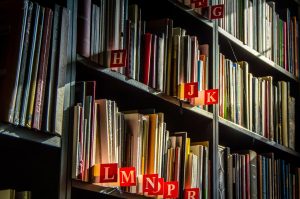I privilegi dello stato debitore? La risposta dell’Unione Europea
Nonostante la normativa europea e italiana imponga l’automatica decorrenza degli interessi moratori nei ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione, alcune sentenze continuano a richiedere un atto formale di costituzione in mora. Questo orientamento contrasta con la ratio della legge speciale e con il diritto UE. Così si favorisce indebitamente la PA, minando la tutela dei creditori e la certezza giuridica

La disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, introdotta in Italia con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE (poi sostituita dalla Direttiva 2011/7/UE), ha rappresentato un punto di svolta nella tutela del creditore, soprattutto nei rapporti con i debiti della Pubblica Amministrazione.
La ratio del legislatore, europeo prima e nazionale poi, è stata quella di predisporre un apparato di tutele rafforzate per contrastare la prassi patologica dei ritardati pagamenti, introducendo un meccanismo di decorrenza automatica degli interessi moratori e un saggio degli stessi significativamente più elevato rispetto a quello legale.
Allora perché parliamo di privilegi dello stato debitore?
Perché nonostante la forte risposta dell’UE in tema di ritardi di pagamento, persistono in giurisprudenza orientamenti che resistono all’applicazione del regime speciale e che purtroppo generano un favor eccessivo verso la Pubblica Amministrazione.
Questo atteggiamento dei Tribunali non fa altro che alimentare la catena dei ritardi oltre che non essere conforme ai dettami dell’Unione Europea.
Un esempio calzante per comprendere il problema è offerto dal Tribunale di Castrovillari con la sentenza 18/01/2023 n. 105/2023 che, nel decidere una controversia relativa al pagamento di interessi moratori su forniture di energia elettrica ad un ente comunale, ha escluso il diritto del creditore in assenza di un formale atto di costituzione in mora.
Il Giudice, pur riconoscendo l’applicabilità del D.lgs. 231/2002, quanto alla misura degli interessi, ha tuttavia negato la loro debenza sulla base di un’argomentazione che merita di essere esaminata nel dettaglio.
Il Tribunale, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale tradizionale, ha affermato che: “gli interessi moratori sulle somme dovute dalla P.A., in ragione della natura “querable” di tali obbligazioni, non decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di adempimento, ex art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., bensì dalla data di formale costituzione in mora, da eseguirsi mediante intimazione scritta ai sensi del comma 1 della medesima disposizione”.
La decisione del Tribunale di Castrovillari, seppur formalmente ancorata a precedenti giurisprudenziali, risulta viziata da un errore di prospettiva fondamentale: l’applicazione di principi generali ad una fattispecie interamente disciplinata da una lex specialis, il D.lgs. 231/2002, la cui ratio è proprio quella di derogare al regime ordinario
Il principio secondo cui i debiti pecuniari della P.A. si qualificano come querable (da adempiersi presso la tesoreria dell’ente debitore), con la conseguente inapplicabilità della mora ex re prevista dall’art. 1219, co. 2, n. 3, c.c. per i debiti portable, è un portato storico della giurisprudenza formatasi sulla base delle norme di contabilità pubblica e del Codice civile.
Tale orientamento, tuttavia, non può trovare applicazione nell’ambito delle “transazioni commerciali” come definite dall’art. 2 del D.lgs. 231/2002.
Il decreto legislativo, infatti, ha introdotto un regime completo e autosufficiente per la decorrenza degli interessi.
L’articolo 4, rubricato “Decorrenza degli interessi moratori“, stabilisce in modo inequivocabile al comma 1 che: “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento“.
Questa disposizione non lascia spazio a interpretazioni che possano reintrodurre la necessità di un’intimazione scritta.
Il legislatore ha voluto esonerare il creditore da qualsiasi onere di attivazione, ponendo l’accento sul mero fatto oggettivo del ritardo. L’automatismo è il cuore della tutela offerta dalla normativa, in linea con gli obiettivi della direttiva europea, che mira a creare un forte deterrente contro i ritardi di pagamento, considerati una delle principali cause di difficoltà finanziaria per le imprese, specialmente le PMI.
Subordinare la decorrenza degli interessi ad un atto formale di costituzione in mora, come fa la sentenza in commento, significa vanificare l’effetto deterrente e l’intento semplificatorio della norma, reintroducendo un onere procedurale che il legislatore speciale ha volutamente eliminato.
L’interpretazione che esige la costituzione in mora si pone, inoltre, in palese contrasto con il diritto dell’Unione Europea e con i principi elaborati dalla Corte di Giustizia.
La CGUE ha più volte ribadito che le norme della Direttiva 2011/7/UE (e della precedente 2000/35/CE) sono volte a garantire che il creditore sia compensato per il danno subito a causa del ritardo (costo del mancato utilizzo del denaro) e a dissuadere il debitore dal pagare in ritardo.
Qualsiasi normativa o prassi nazionale che renda più difficile o oneroso per il creditore ottenere tali interessi è incompatibile con l’obiettivo e l’effetto utile della direttiva.
Un’interpretazione conforme al diritto e alla sua ratio non solo garantisce la certezza dei rapporti giuridici, ma contribuisce a promuovere una cultura della puntualità nei pagamenti da parte del settore pubblico, a beneficio della liquidità e della competitività dell’intero sistema economico.
La resistenza dei Tribunali a questo principio consolidato rappresenta un ostacolo importante che deve essere superato per evitare appunto dei privilegi a favore della Pubblica Amministrazione e una non corretta e uniforme applicazione della legge.